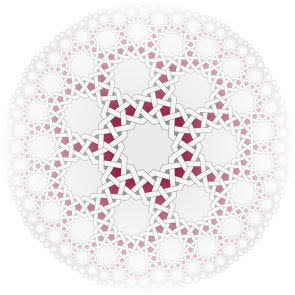Prospettive Sacre d'Oriente e d'Occidente
Il Fine Ultimo dell'Uomo
La dottrina indiana del fine ultimo dell’uomo1
Ananda K. COOMARASWAMY
La religione dell’India è conosciuta come Induismo o Brahmanesimo. Di questa religione, il Buddhismo fu una variante, in rapporto con l’Induismo allo stesso modo in cui il Protestantesimo lo fu col Cattolicesimo.
Quando la religione dell’India fu inizialmente esaminata dagli Europei, e principalmente dai missionari cristiani, non poterono esser viste altro che delle differenze fra Cristianesimo2 e Induismo; perché nessuno desiderava riconoscervi altro che differenze. Sappiamo ora che i paralleli fra Cristianesimo e Induismo sono così tanti, così stringenti e perfino così verbalmente esatti da poter solo ritenere che entrambi siano dialetti dello stesso e unico linguaggio spirituale; rimanendo soltanto questa distinzione, che nel Cristianesimo la maggior enfasi è devozionale ed etica, nell’Induismo metafisica e intellettuale. Se consideriamo solo il Cristianesimo medievale, o la dottrina Cattolica, perfino questa distinzione parzialmente scompare.
Persistono ancora moltissime concezioni erronee sulla religione indiana, perfino nelle cerchie degli studiosi. L’Induismo, ad esempio, viene descritto come un politeismo, ma non è più politeista del Cristianesimo, in rapporto al quale potreste essere sorpresi di apprendere che nientemeno che un’autorità come S. Tommaso d’Aquino afferma: «Non possiamo dire l’unico Dio, perché la deità è comune a più d’uno»3. E proprio come i musulmani4 hanno erroneamente guardato al Cristianesimo come a un politeismo, così i cristiani sono stati in errore nel chiamare l’Induismo un politeismo, perché il fatto è che né il Cristianesimo né l’Induismo sono politeisti, sebbene entrambi siano polinominalisti; essendo difatti inevitabile un’infinità di designazioni del Primo Principio, precisamente a causa della Sua infinita varietà e onnimodalità se considerato dal nostro punto di vista, per quanto perfettamente semplice e unico e lo stesso possa esser Esso in Se stesso.
Allo stesso modo l’Induismo è stato spesso chiamato una fede panteistica, essendo il panteismo la dottrina per la quale tutte le cose sono Dio e Dio è identico a tutte le cose e non è al tempo stesso infinitamente più grande di tutte le cose. Difatti, però, questa dottrina viene ripudiata ripetutamente e con enfasi nell’Induismo mediante ripetute affermazioni sia dell’immanenza che della trascendenza della Deità, e con la reiterata distinzione degli aspetti finiti e intellegibili da quelli infiniti e inintellegibili della Deità stessa.
Contemporaneamente ci imbattiamo in ripetute affermazioni dell’identità con l’Essenza Divina, non certo dell’ego empirico, bensì dell’intimo e spirituale sé dell’uomo, in logoi egualmente famosi come «Quello sei tu» ed «È solo col diventare Dio che si può veramente adorarLo». Questo ci porta faccia a faccia col problema di cosa realmente significhi la dottrina indù della deificazione, e alla domanda se la «deificazione» indù differisca dalla «deificazione» cristiana come è intesa, ad esempio, da S. Bernardo o da Meister Eckhart.
Dal punto di vista indù non può esservi altra questione se non che il fine ultimo e la beatitudine dell’uomo sono realizzati solo quando egli non sappia più nulla di una distinzione tra «se stesso» e lo Spirito di Dio; proprio come, per usare una similitudine comune a Ruisbroek e alle Upaniṣad, quando i fiumi raggiungono il mare, la loro individualità si confonde con quella del mare e possiamo solo parlare di «mare»5.
Se d’altro lato il Cristianesimo sembra sostenere un’eterna distinzione della creatura dal Creatore, dobbiamo chiederci se l’apparente disaccordo sia reale o meno, e se la «deificazione» indù e quella dei mistici cristiani (che pure sono stati accusati di panteismo), con l’insistenza sul totale abbandono di sé quale condizione indispensabile, non implichino precisamente quella vera distinzione della creatura dal Creatore, e del finito dall’Infinito, che non è semplicemente una dottrina ortodossa cristiana, ma è anche la sola metafisicamente inattaccabile e universalmente valida6. È dell’immortalità dell’anima che ci stiamo occupando; se tale immortalità sia possibile e, ciò che è più importante, se l’immortalità dell’anima, posto che sia possibile, possa essere considerata compatibile o meno, sotto ogni aspetto, col fine ultimo dell’uomo della deificazione e della perfetta beatitudine.
La dottrina indù e quella cristiana concordano nel fare del Messia e dell’Avatara, Uomo universale e Sole degli Uomini, l’unica porta attraverso la quale si può essere espansi da questo mondo creato, di nascita e morte, di mutamento e corruzione, dentro quel mondo increato, di luce e immortalità; dalla nostra presente esperienza di passato e futuro, dentro quell’eterno ora senza durata. È con riferimento a questo grande transito che Cristo dice: «Chi volesse salvare la sua vita, che la perda»7; e davvero, come esclama Eckhart, «L’anima deve mettersi a morte ... Tutte le scritture gridano a gran voce la libertà da se stessi». Questa «libertà da se stessi» significa tantissimo di più del nostro «altruismo» etico; significa una totale liberazione dall’idea di «io e mio», da ogni attaccamento alla nozione di un’indipendente essenza privata sia dell’anima che del corpo; e una liberazione da ogni attaccamento a qualsiasi «sopravvivenza di personalità» nel modo in cui è stata confusa dagli spiritualisti con l’ «immortalità» nel senso ortodosso e strettamente spirituale della parola.
Questa porta solare e messianica attraverso la quale si trapassa da questo mondo imperfetto nello stato di gloria che, come dice S. Tommaso d’Aquino, «non è sotto il sole», è un varco stretto, e finanche una porta chiusa per coloro che non sono qualificati a passarvi attraverso; la via è cioè impercorribile per coloro nei quali rimanga la più piccola traccia di individualità, sia fisica che psichica. Per «giungere al di là del Sole» si deve aver abbandonato ogni possesso, sia del corpo che dell’anima; quelli che sono qualificati a entrarvi sono descritti come «unificati», a differenza di tutti coloro che rimangono al di fuori, nella molteplicità. Le porte del Paradiso sono custodite dall’Angelo con la Spada Fiammeggiante, ed è precisamente allo stesso modo che nelle scritture indiane l’ingresso è descritto come ricoperto, celato e difeso da raggi di luce; da tali manifestazioni esteriori la via è sbarrata contro coloro che sono agnostici di Dio.
È solo per uno che sia trasformato dalla Gnosi di Dio che i raggi vengono ritirati, e si vede una strada aperta, coincidente con ciò che nell’Induismo è chiamato «Raggio Preminente», e nel Cristianesimo «Raggio Oscuro», perché non è visibile esternamente, ma penetra nell’Oscurità Divina dove non splende alcun Sole, ma solo lo Spirito che è chiamato ugualmente, nell’Induismo e nel Cristianesimo, la «Luce delle luci».
Nelle scritture indiane le qualificazioni di chi sia abilitato a passare attraverso il Sole e ad entrare nella Divinità «come latte potrebbe essere versato nel latte» sono in primo luogo quelle della Verità e dell’Anonimato. È come «uno la cui natura è la Verità» che ci si accosta al Sole, che «è la Verità»; essendo della stessa qualità, non si può essere respinti. Oppure è come chi in risposta alla domanda «Chi sei?» può dire «Colui che sono, cioè la Luce, Tu stesso» ed è allora invitato: «Entra, tu, perché ciò che Io sono, tu sei, e ciò che tu sei, Io sono»8. Ma se rispondesse col nome proprio o con un cognome, il pretendente all’ammissione sarebbe trascinato via dagli agenti del Tempo9. Perché, come espone un altro testo, «Dio non è venuto da alcun luogo, né è divenuto alcuno»: e ne segue inevitabilmente la conclusione che nessuno può tornare a Dio come simile a simile se è ancora qualcuno.
Allo stesso modo chi raggiunge la fine della strada ed entra in Dio deve lasciare dietro di sé l’intero fardello delle sue azioni, buone o malvagie che siano. Perché queste sono le basi del «carattere», e nulla di caratteristico può entrare nella non-caratterizzata Deità, «della Quale la sola idiosincrasia10 è l’essere». Là, come dice Meister Eckhart, «Né vizio né virtù sono mai entrati», o come dicono le Upaniṣad, «Né vizio né virtù possono passare sopra quel Ponte dello Spirito che è l’unico collegamento tra questo e quel mondo». Secondo le parole del Damasceno, «Colui Che È, è il principale dei nomi che si applicano a Dio»11; e nelle Upaniṣad, «Egli È, solo per questo Egli può essere afferrato»12. Non è quindi grazie a opere o merito che si viene qualificati a conseguire la perfezione della felicità, ma solo per un’assoluta Conoscenza e Amore di Dio; un’assoluta conoscenza o amore di qualsiasi cosa implicando, ovviamente, una perfetta identicità di conoscitore e conosciuto, di amante e amato.
Siamo ora in una posizione tale da riconciliare i concetti mistici cristiani e metafisici indiani di «deificazione» con la dottrina, vera per comune ammissione, che nulla di finito può entrare nell’Infinito come simile nel simile. Egualmente, dal punto di vista cristiano e indù la costituzione dell’uomo è triplice, una costituzione, cioè, di corpo, anima e spirito; in sanscrito råpa, nàma, àtman. L’anima cristiana (anima, psyché) è non meno del corpo una cosa creata e mutevole, e perciò, secondo le parole di S. Tommaso d’Aquino, «Dire che l’anima sia di Sostanza Divina implica una manifesta inammissibilità»13. Se poi, nondimeno, si dice talvolta che l’anima diviene immortale benché abbia avuto inizio nel tempo, ed essendo solo una tra altre, non dobbiamo trascurare che questa trasformazione viene compiuta solo con la sua «ultima morte», né che è solo come «nulla» e «nessuno» che essa può entrare in Dio, il Quale sicuramente non è alcunché, né alcuno tra gli altri.
La coscienza di un uomo può essere centrata nel suo corpo, e questo è l’uomo animale; o nell’anima, e questo è l’uomo psichico; o nello spirito, ed è l’uomo spirituale o pneumatico. E’ solo quest’ultimo che può «ritornare» a Dio in somiglianza di natura. Né questa fine ultima dell’uomo è meramente materia di destino post mortem; perché «Il Regno dei Cieli è dentro di voi»14, o come dicono le Upaniṣad, «L’inconcepibile forma della Deità, più lontana del lontanissimo ma anche qui dentro di voi, benché non possa essere vista con la facoltà intrinseca dell’occhio, può essere afferrata mediante la Verità e può essere vista dallo Gnostico illuminato, nel quale Essa inabita la segreta camera del cuore».
Così né la «deificazione» indiana né quella cristiana, fine ultimo dell’uomo, implicano una dottrina tale che l’individualità umana limitata e variabile possa assumere l’essere infinito e immutabile di Dio. La deificazione è una riunione, spesso descritta come un matrimonio, dell’immanente col trascendente Spirito. Non che questi due siano mai stati divisi altrimenti che nei termini della logica umana, dalla quale sono sostenute le nostre stesse limitate individualità; giacché lo Spirito è indivisibile. Essere deificato è «werden was du bist»15: è solo quando l’Identità viene considerata una condizione da realizzarsi «un giorno», e solo parlando in termini troppo-umani16, che chiamiamo la Gnosi una ri-unione, e parliamo di coloro che la realizzano come di «Perfezioni», quasi essi fossero mai esistiti in qualche luogo e fossero mai stati men che perfetti. Di fatto, come dice Eckhart, «Quando io entrerò là, nessuno mi chiederà donde io sia venuto o dove sia andato». Giacché il principio individuale «non ancora» si è rialzato, «non ancora» è a casa, solo nella misura in cui concepisce se stesso nel tempo e come un figliol prodigo; dato che esso è in Dio non è mai caduto, non è stato mai estraniato. Giacché in Dio non può esservi alcuna distinzione delle idee dall’intelletto che le concepisce; è solo «come se» che si può parlare dell’imago imaginata che «torna a» o «diviene» l’imago imaginans, nella quale già esiste «più eminentemente».
Quindi la «deificazione» indù è precisamente quel che viene significato quando ci viene comandato «Siate perciò perfetti, come è perfetto il Padre vostro nei Cieli»17, e quel che viene significato da San Paolo quando dice che «Chiunque sia unito al Signore è un solo Spirito»18. Così una distinzione fondamentale tra Induismo e Cristianesimo è impossibile; tracciare una distinzione sarebbe come dividere la Verità da se stessa.
(traduzione e note a cura di Franco GALLETTI)