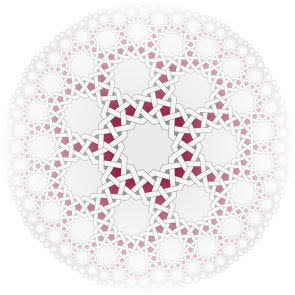Prospettive Sacre d'Oriente e d'Occidente
Il Fine Ultimo dell'Uomo
INTRODUZIONE
I seminari di studi che abbiamo intitolato Prospettive sacre d’Oriente e d’Occidente, di cui presentiamo gli Atti del primo incontro palermitano, nascono dal matrimonio di due animi: quello prettamente accademico dell’Officina di Studi Medievali, aperto allo studio delle diverse espressioni religiose e filosofiche, con alle spalle un’ampia esperienza di ricerca in campo internazionale, e quello, proprio di Perennia Verba, rivolto a investigare la Philosophia Perennis che in qualche modo soggiace, in forma più o meno evidente, dietro le grandi espressioni del sacro. Lo scopo di tale unione, cementato dal comune criterio di rigore scientifico, è quello di proporre un milieu intellettuale che aiuti a illuminare e soprattutto a meglio focalizzare gli spazi del sacro nelle sue molteplici declinazioni.
La nostra è un’epoca in cui non ci si può più permettere d’ignorare l’“altro”: chi proviene da una cultura diversa dalla nostra e da mondi dove tradizioni millenarie fanno comunque da sfondo anche ai più svariati e spinti processi rivoluzionari indotti dalla globalizzazione. La diversità non dev’essere vista come possibile causa di conflittualità, né portarci a paventare lo scontro di civiltà teorizzato da Samuel Huntington. Essa dev’essere piuttosto uno stimolo all’arricchimento delle nostre rispettive culture di appartenenza, grazie a una comprensione più profonda ed universale indotta dallo studio del sacro e delle tradizioni arcaiche dell’umanità. Solo una visione capace di osservare la Verità nei suoi molteplici aspetti, analoga a quella di colui che, ponendosi in cima alla montagna, è in grado di percepire le molteplici vie che portano alla sua vetta, sa apprezzare le differenze e coglierne l’unità essenziale.
Continuiamo, spesso inutilmente, a parlare di dialogo... dialogo di civiltà, dialogo interculturale, dialogo interreligioso. Il risultato è nella maggior parte dei casi deludente e non possiamo non chiedercene la ragione. Dobbiamo guardare indietro, lungo il percorso intrapreso, e cercare di valutare onestamente le ragioni dei fallimenti. Il primo passo sarà quello di porci nei confronti degli altri, non come gli unici depositari della Verità, bensì come i depositari di un’espressione della Verità, la quale, di per sé, non può essere limitata da alcuna forma. Riferendosi alla natura della rivelazione, Junayd, maestro vissuto a Baghdad nel III secolo dell’égira, disse che «l’acqua assume sempre il colore del recipiente che la contiene», volendo significare con ciò che la Verità in se stessa non ha alcuna “tinta” che la caratterizzi, quest’ultima procedendo sempre e soltanto dal ricettacolo umano che la riceve ed è eventualmente destinato a veicolarla.
La Verità, già per S. Agostino, è una Sapienza increata sic est, ut fuit, et sic erit semper, e ancor prima di lui, Clemente Alessandrino scriveva che la stessa identica Verità si trova espressa, rivestita in molteplici forme, sia dai Brahmani sulle rive del Gange, che dai Caldei, che nei misteri dei sacerdoti Egizi, poiché sempre ispirata da uno stesso – per dirla in termini cristiani – Verbo eterno. Questo è anche lo spirito universale cantato da Hallâj, da Rumî e da Ibn ‘Arabî, uomini per i quali la Vera Religione, dal tempo primordiale fino al Giorno della Resurrezione, è una e identica presso tutte le religioni rivelate quanto alla sua realtà essenziale, poiché la differenza non concerne che la forma e si tratta d’una differenza di linguaggio che non sopprime l’identità originale e l’unità metafisica. S. Ambrogio, citato da S. Tommaso d’Aquino, affermava che, «ogni verità, non importa dov’essa si trovi, ha sempre per autore lo Spirito Santo». Secondo A.K. Coomaraswamy, uno dei maggiori testimoni del nostro tempo della Philosophia Perennis, «la filosofia metafisica è chiamata perenne a causa della sua eternità, universalità e immutabilità... Ciò che è stato rivelato all’origine contiene implicitamente l'intera Verità... la dottrina non ha storia»1.
Investigare nelle tradizioni sacre dell’antichità, nel patrimonio dimenticato, è quindi la premessa indispensabile per comprendere le ragioni dell’altro, e qualora non saremo arrocati nelle specificità della nostra “forma”, forse saremo in grado di capire che le differenze di linguaggio non preludono necessariamente a differenze di significato. Questa ricerca, all’epoca attuale, può ben servirsi degli strumenti scientifici tipici della cultura accademica, senza per questo snaturare il messaggio sapienziale che le culture metafisiche del passato ci hanno lasciato in eredità. Sicuramente rischieremo di scoprire percorsi che vanno in una direzione diversa da quella del mondo moderno, ma forse questa è l’unica porta rimasta aperta all’uomo contemporaneo per riscoprire principi dimenticati e sentieri che portano ad una conoscenza di Dio che è soprattutto conoscenza di noi stessi. Percorsi scevri dalle intemperanze dell’intolleranza che deriva dall’ignoranza e dalla paura di perdere la propria identità culturale. Secondo colui che scrive, non è di questa paura che dobbiamo preoccuparci, bensì di quella di non riuscire a ritrovare la nostra vera identità a motivo dell’eccessivo attaccamento alla nostra individualità, puramente contingente e priva di alcuna consistenza metafisica. L’Uomo interiore non s’identifica a quello esteriore, che non ne è che un simulacro. È per questo che nel Vangelo è detto che «chi ama la sua anima la perderà» e che tutte le dottrine metafisiche c’insegnano a «morire prima di morire» al fine di rinascere nuovamente.
Ci è sembrato giusto esordire questa serie di studi col tema del Fine ultimo dell’uomo, poiché è solo dopo che avremo compreso la raison d’être della nostra esistenza, che potremo orientare le nostre aspirazioni e facendo questo abbiamo preso spunto dal testo di A.K. Coomaraswamy: «The indian doctrine of man’s last end»2, di cui presentiamo anche, unitamente agli Atti, una traduzione italiana.